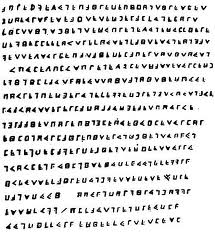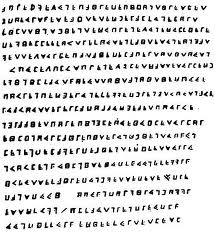Augusto Franzoj salì faticosamente il sentiero sulla collina stringendo tra le mani deformate dall’artrite il calcio di due pistole acquistate 11 anni prima a New York.
Raggiunta la cima si sedette sotto un albero e osservò Torino illuminata dal sole primaverile.
Fermò lo sguardo sul falso minareto appena costruito nel quartiere dell’Esposizione Internazionale e pensò a quanti ne aveva già incontrati, minareti veri con i muezzin che chiamavano i fedeli alla preghiera.
Da tempo sapeva che non sarebbe più andato in nessun luogo, perché a 63 anni aveva esaurito le forze e le risorse.
Pochi giorni prima “un povero travet ferroviario, che aveva avuto un tozzo di pane per merito suo e che egli amò come un figlio, dovette correre per tutta Torino alla ricerca di 100 lire per pagargli l’affitto e si sentì rifiutare l’obolo di Belisario da tante personalità insigni o pseudo insigni”.
Franzoj capì che era arrivato il momento di farla finita.
Si disse che lasciava assai poco in sospeso, forse solo un sogno, un ultimo sogno che lo aveva accompagnato negli anni del decadimento: tornare nel Corno d’Africa per trovare un tesoro di carta, rinchiuso in una cassa di legno con incise due lettere: AR.
Quel tesoro lo aveva visto, erano decine di taccuini e centinaia di fotografie.
Era la cassa di Arthur Rimbaud, che incontrò per caso a Tadjura, “un piccolo villaggio dancalo con qualche palmizio e qualche moschea, un forte con 6 soldati francesi e un sergente”.
Franzoj era alla ricerca dei laghi equatoriali e Rimbaud aspettava notizie per concludere un affare che, era certo, lo avrebbe fatto diventare finalmente ricco.
“Mi trovo qui per formare una carovana per lo Scioa – diceva – Ho un carico di vecchi fucili a stantuffo in disuso da quarant’anni che dai venditori di armi usate, a Liegi o in Francia, valgono 7, al massimo 8 franchi, al pezzo. Al re dello Scioa, Menelik II, li venderò a una quarantina di franchi.”
Franzoj conosceva i versi di Rimbaud, ma gli ci volle un po’ per realizzare che quel trafficante d’armi, neppure troppo onesto, era la stessa persona che Paul Verlain definiva un genio; non sapeva che aveva abbandonato Parigi otto anni prima, dopo aver fatto a pezzi tutti i canoni della poesia e averli rimontati in qualcosa di diverso, di rivoluzionario.
Da allora di lui non se ne seppe più nulla, ma furono in pochi a lamentarne l’assenza.
I suoi maestri parnassiani, che avendolo tra i piedi rischiavano di trovarsi trasformati, dall’oggi all’indomani, in vecchi arnesi della retorica rimata, tirarono un sospiro di sollievo quando sparì.
“Scolpisci, lima, cesella; che il tuo sogno fluttuante si sigilli nel sasso resistente!” Diceva Théophile Gautier, il Gran Maestro che teorizzava l’arte per l’arte, fine a sé stessa, pura sagra della bellezza.
Altro che scolpire lavorando di cesello e di lima, rispondeva Rimbaud, altro che sagra della bellezza: “Si tratta di fare l’anima mostruosa, come un uomo che si pianti verruche sul viso e le coltivi; bisogna farsi veggente mediante un lungo, immenso e ragionato disordine di tutti i sensi.”
Persino sua madre si dovette sentire in qualche modo sollevata dall’uscita di scena di un figlio così pubblicamente scandaloso, che andava finalmente a insabbiarsi tra le lande desolate della Somalia e l’altopiano fratturato dell’Etiopia, lontano dall’amabile, rozzo e incolto perbenismo della sua cittadina delle Ardenne.
Nei giorni di Tadjoura tra Rimbaud e Franzoj nacque una vera amicizia.
Ugo Ferrandi, compagno di viaggio di Franzoj, racconterà che li vedeva spesso “impegnati in lunghe discussioni letterarie, dai romantici ai decadenti.”
Per quel che si sa, questa fu l’unica volta, nella breve vita africana, in cui Rimbaud tornò a parlare di qualcosa che apparteneva al passato.
Dalla cassa su cui erano incise le sue iniziali prendeva mazzi di fotografie e taccuini dai quali leggeva poesie che raccontavano la sua Africa, le donne etiopi, la luna di Harar.
Solo dopo il rientro in Italia Franzoj scoprì che Rimbaud non aveva pubblicato nessuno di quei versi e si rese conto dell’unicità dell’incontro, del privilegio che gli era stato concesso.
Nel 1891 il poeta morì per un tumore al ginocchio: aveva 37 anni e la sua fama si dilatò fino a farlo diventare uno dei più grandi dell’800.
Franzoj attese inutilmente l’uscita degli scritti africani.
La cassa era scomparsa, persa lungo il tragitto che avrebbe dovuto portarla in Francia, dimenticata in qualche magazzino tra Harar e Aden.
Passò anni cercando di organizzare una spedizione per ritrovarla, ma le autorità italiane gli impedirono di tornare in Etiopia.
A un uomo dal carattere spigoloso, capace di reagire d’istinto a ogni ingiustizia, che non sopportava i malonesti e i lacchè, non si poteva consentire di andare in luoghi nei quali il governo vagheggiava ambizioni coloniali.
Non ci si poteva fidare di un cane sciolto, di un amante degli eccessi, di un rivoluzionario scapigliato finito spavaldamente in carcere per i suoi ideali; di uno che era stato capace di sfidare con un unico gesto cinque ufficiali dell’esercito regio e di batterli tutti in una sola mattinata; non era pensabile dar credito a chi aveva spinto all’infedeltà stuoli di donne ben maritate.
Venne messo in un angolo, dimenticato, anche se Giosuè Carducci e Cesare Correnti erano suoi estimatori, anche se era stato il primo e il più brillante tra gli inviati speciali della Stampa.
Negli anni in cui il giornalismo era prosa leziosa, lui scriveva per sintesi e per immagini:
“Massaua è il più sgradito porto del Mar Rosso. Ai tempi di Mosè questo era il mare prediletto da Dio. Ora Dio l’ha dimenticato. Tutte le 10 piaghe d’Egitto sono venute qui a lasciare parte delle loro miserie. Caldo acrobatico, 40 gradi all’ombra, afa, zanzare, vento e noia, e l’amministrazione egiziana più fastidiosa del vento Kamassin! Strade difficili, torrenti impetuosi, vegetazione superba, fauna svariatissima, storie sventurate, soli splendidi e miti, notti andalusiane, acqua fredda come il ghiaccio, fame inesauribile come la bontà di Dio, profumi inebrianti, bazi-buzuck manigoldi idem, idem come da Kalameda. Se si vuole aggiungere ad ogni costo qualche cosa si dice che gli abiti degli indigeni andavano, mentre mi inoltravo, semplificandosi a vista d’occhio, tanto che uomini e donne finivano a mostrare ciò che il buon Dio nostro, ma soprattutto le nostre questure, vogliono assolutamente si tenga celato.”
Era un grande Franzoj!
Fu l’ispiratore di Emilio Salgàri che, poveraccio, schiavizzato per poche lire dal suo editore, in sedici anni diede alle stampe 84 libri e bevve 5.844 bottiglie di Marsala senza muoversi da Torino, rispettando con masochistico rigore l’impegno contrattuale di consegnare ogni ventiquattro ore tre pagine pronte per la stampa: 17.532 pagine in sedici anni.
Erano le 10 e mezza del 13 aprile 1911, giovedì di Pasqua, e Augusto Franzoj, seduto sotto l’albero in cima alla collina, non ripercorse affatto il cammino nostalgico del suo passato: guardò Torino per l’ultima volta senza provare alcuna emozione, salutò con un infantile rimpianto il suo ultimo sogno, la cassa di Rimbaud, poi, sospirando, puntò le due pistole alle tempie, tirò simultaneamente i grilletti e i revolver americani eseguirono impeccabilmente il compito per cui erano stati creati.
Le pallottole incrociarono le loro traiettorie al centro del cervello poco prima di fargli esplodere la scatola cranica.
Salgàri si ispirò a lui anche quando, finalmente, decise di sciogliere il contratto con il suo editore: 12 giorni dopo andò armato di rasoio nel boschetto della Madonna del Pilone, a 4 chilometri dalla collina scelta dall’amico, e fece seppuku come un samurai per poi squarciarsi la gola. Nulla a che vedere con il gesto estremo d’avanguardia, senza fronzoli, senza rituali, di una testa che esplode in direzioni opposte con moto uniforme per creare il massimo della scapigliatura.